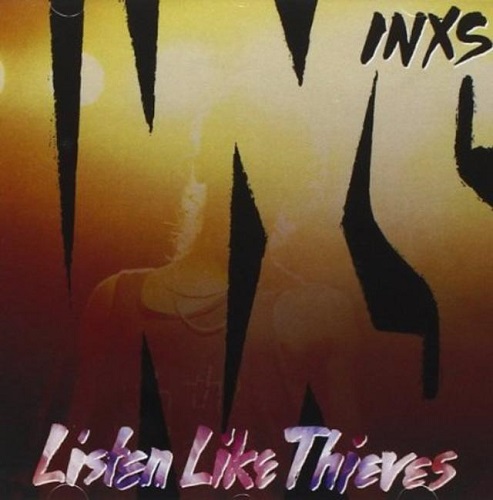Quando il purismo, non importa di quale segno, ha fatto solo danni. Potremmo iniziare così questa nostra inchiesta storico-musicale, volta a riconsiderare – e rivalutare, perché bisogna, ora, deporre i pregiudizi – dischi e gruppi, emersi al tempo della new wave, che, a causa della fama, hanno fatto (e tuttora fanno) storcere il naso a molti. Ingiustamente, però, dato che prima di svoltare verso suoni e soluzioni di tipo sfacciatamente commerciale, quegli artisti hanno fatto talvolta altro, e sovente con risultati tanto eccellenti quanto purtroppo dimenticati o misconosciuti.

L’anno-cardine, terminato il primo e più noto fermento punk (1976-78), fu il 1979. Nel giro di pochi mesi videro la luce dischi importanti ed iniziatori. Tra questi, sono assolutamente da segnalare il LP d’esordio di Adam and the Ants (Dirk Wears White Sox fu un formidabile incrocio di retaggio punk e dark sperimentale, ed il successo arrivò solo dopo) e Life in a Day, debutto degli scozzesi Simple Minds. Il gruppo di Jim Kerr e Charlie Burchill si spinse ancora più in là, con il successivo Real to Real Cacophony (1979, impregnato di umori alla Can di Tago Mago) e soprattutto con Empires and Dance (1980, permeato di oscura e obliqua ricerca elettronica). Suoni tedeschi, con membri dei Can in cabina di regia, anche per il primo Eurythmics (In the Garden, 1981), proprio due anni prima di Sweet Dreams. Ed entusiasmante new wave sintetica pure per gli australiani INXS degli anni 1980-84, prima che virassero verso un (peraltro brillante) hard pop da classifica.
Anche la fase 1978-80 degli Human League di Sheffield (formatisi sulle ceneri dei Future), prima cioè del successo mondiale di Dare (1981), produsse un EP (The Dignity of Labour) con marziali e incalzanti strumentali di sintetizzatore, nonché due dischi che mostravano apertamente il debito del nuovo pop-rock elettronico verso il varco aperto in Gran Bretagna dal post-punk, varco per il quale passarono pure gli avventurosi – e, almeno a inizio carriera, quasi rumoristici – Cabaret Voltaire. Il primo disco degli OMD di Liverpool, inciso nel 1979 e pubblicato nel 1980, mostrava anch’esso un taglio freddo e minimalista (Colonia e Dusseldorf restavano evidentemente due modelli, cui rifarsi e guardare). Ed anche Organisation, il disco (del 1980) che conteneva il fortunatissimo 45 giri Enola Gay, era un album completamente diverso dal suo singolo trainante, con scelte sonore malinconiche ed autunnali, poco appariscenti e quasi impalpabili nella loro colta orchestrazione di fondo. Occorre rimarcarlo e rifletterci sopra adeguatamente. Anche qui, scelte più facili furono compiute soltanto in seguito, dal pessimo Junk Culture (1984) in poi.

E che dire dei Visage? Si trattava, per riprendere la terminologia in voga tra fine anni ’60 e primi ’70 sulla carta stampata, di un super-gruppo, che comprendeva membri e collaboratori di Ultravox, Rich Kids e Gary Numan, con sugli scudi arrangiamenti sopraffini, recitati femminili, ottime capacità di scrittura ed esecutive (pensiamo solamente al grande violinista e tastierista Billy Currie, il Paganini della new wave inglese, senza voler esagerare). Altro fondamentale anello di congiunzione tra punk del 1978 e ‘nuova onda’ britannica fu l’ex Generation X Billy Idol, che da solista – come il massimo giornalista e storico del punk, Jon Savage, ha sottolineato, in England’s Dreaming – ha ottenuto il suo meritato successo. L’artista, nel prosieguo della sua carriera, si è confrontato anche con la fanta-scienza (in Cyberpunk, del 1993) ed è, di recente, tornato sulle scene, con Kings and Queens of the Underground, ottimo lavoro di AOR moderno e moderatamente tecnologico. A suonare le tastiere e i sintetizzatori sul disco è stato tra l’altro un maestro del pomp rock, Geoff Downes, l’ex leader (con alla voce Trevor Horn, poi con lui negli Yes e celeberrimo produttore) dei Buggles di Video Killed the Radio Stars, una delle canzoni simbolo del 1980 in tutta Europa.
Eccoci quindi a trattare – ebbene sì, è giunta l’ora di farlo – dei Duran Duran. Nati a Birmingham, nel 1978, con uno stile tra glam rock e post-punk, in principio con Stephen Duffy alla voce, i cinque debuttarono con l’ottimo e troppo sottovalutato esordio omonimo, nel 1981: un grande disco di new wave elettronica, con il fantastico strumentale Tel Aviv in chiusura, lavoro che ben poco poteva fare presagire del successo planetario di qualche anno dopo. Rio (1982) iniziò a sbancare i botteghini – è vero – però conteneva ancora un brano eccellente, The Chauffeur, scritto nel 1978 ed intriso di echi progressivi, che si dipanano nei sette minuti del pezzo soprattutto con il notevole lavoro tastieristico di Nick Rhodes. La svolta, totalmente e solo commerciale, giunse con il terzo disco, Seven and the Ragged Tiger (1983), insipido e banale. Le quotazioni del gruppo si risollevarono tuttavia subito col live Arena (1984, molto rock nelle esecuzioni). Dalla band di Birmingham derivarono a quel punto gli Arcadia (1985, David Gilmour fra i prestigiosi collaboratori) ed i techno-funkers Powerstation (con alla voce Robert Palmer, che aveva scoperto il synth-pop in Clues nel 1980). I Duran Duran si rimisero assieme solo nel 1986, per il debole Notorius, che sprecava il riferimento ad Hitchcock del titolo per una sciatta e commerciale mistura mal digerita di pop, dance, r ‘n’ b e smooth jazz. Meglio (almeno in parte) fece Big Thing, due anni più tardi. Quindi crisi, sbandamenti ed abbandoni, sino al ritorno, qualche anno fa, con una serie di CD discreti, che guarda il caso ritornano parzialmente alle origini. Risale al 1987, infine, l’esordio solista Thunder, di Andy Taylor, classico lavoro di hard rock inglese, inserito dagli specialisti d’oltremanica tra i 100 top album nella storia della chitarra. Forse troppo, comunque un disco di qualità e da riscoprire, edito un anno prima che Taylor producesse (e suonasse magistralmente, da vero e autentico professionista) in Out of Order di Rod Stewart (1988).
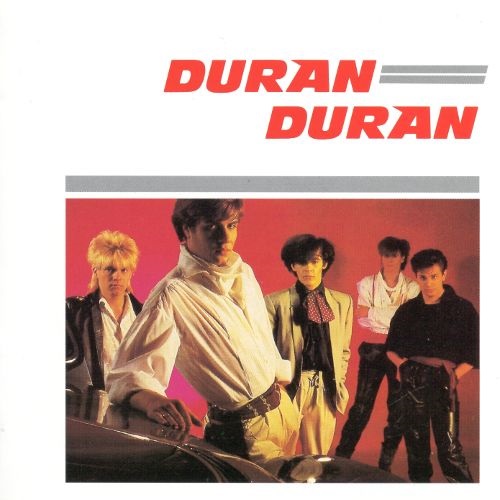
Discorso assai simile si può fare per i ‘cugini-rivali’ Spandau Ballet. Dal loro terzo disco, col quale svoltarono verso un soul-pop levigato, e baciato da enorme successo commerciale, nessun critico o giornalista li ha mai voluti considerare. Anche, mi permetto di dirlo, per pregiudizio o partito preso: chi e quando ha stabilito che chi ‘vende’ non vale nulla? Rammentiamo che, nella storia del rock, si sono trovati ai primi posti delle classifiche mondiali nomi storici ed imprescindibili, come Jefferson Airplane, Grateful Dead, Bob Dylan, Pink Floyd, Yes, Genesis, Jethro Tull, Elton John, Billy Joel, Supertramp, BJH, ELO, ELP, Asia, Journey, Foreigner, REO Speedwagon, Springsteen, U2, Guns ‘n Roses, Iron Maiden, Metallica, Marillion… E che in Germania, paese da sempre attento al valore e alla qualità della cultura musicale, ai primi posti delle charts abbiamo avuto, proprio in questi mesi, band metal, inossidabili ed incorruttibili, come i Powerwolf e gli Immortal. Ma lasciamo perdere: chi scrive non vuole di certo fare polemica, solo ricostruire verità di fatto, colpevolmente ignorate o volutamente fatte passare sotto silenzio a causa di preconcetti arbitrari.
Torniamo agli Spandau Ballet. Quando non erano ancora nessuno, i cinque inglesi realizzarono, nel 1981, il loro debutto, Journeys to Glory. Intanto, il disco era prodotto da Richard James Burgess, un vero mago della ricerca elettronica inglese. Inoltre, i pezzi del disco palesavano un approccio molto post-punk, con due chitarre affilate e taglienti, suoni squadrati e geometrici, atmosfere tese e spesso cupe, due sintetizzatori, dalle timbriche gelide ed algide, canzoni freddissime e molto ‘tedesche’: un rock elettronico e quasi futuristico, che flirtava sommamente con le nuove tecnologie di allora, non senza una produzione pazzesca e avveniristica. Un capolavoro, anche se nessuno osa ammetterlo. E si tratta di un grave errore, diciamolo chiaro. Con il secondo disco – rifiutando intelligentemente di ripetersi – il quintetto albionico continuò il suo lavoro con il geniale Burgess: sulla prima facciata, a parte lo stupendo singolo Instinction (che rimandava alle sonorità dell’esordio), gli altri tre pezzi si rivolgevano piuttosto a soluzioni ritmate ed accattivanti di marca funky rock; le tracce della seconda facciata, a cominciare da una sublime cavalcata, alla Ultravox, She Loved Like Diamond, tornavano al sound del primo album, con, in più, le suggestioni e misteriose e rarefatte di Pharaoh, e le scale orientali degli ultimi due brani, in grado di anticipare certi schemi cari, in seguito, al duo Sylvian-Sakamoto. Il resto è storia nota: dal 1983 gli Spandau Ballet furono, di fatto, un altro gruppo, che cambiò genere ed incontrò una fama crescente (con dischi comunque gradevoli, per quanto di puro easy listening).
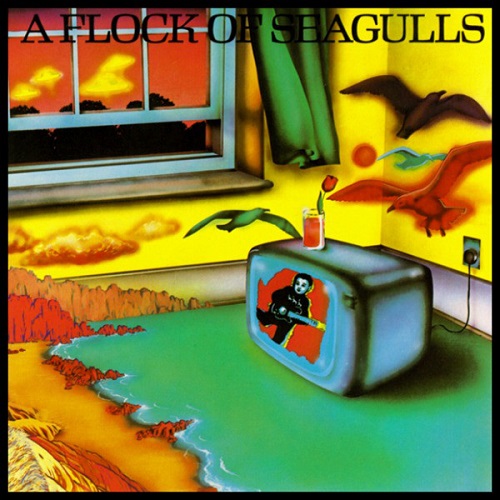
Chiudiamo questa breve rassegna con la scuola definita, già a quel tempo e non senza toni alquanto dispregiativi, new romantic: molto facile e assai sbrigativo, allora come oggi, sottostimare gruppi in realtà interessantissimi, come i Classix Nouveaux, campioni di un decadentismo in musica capace di unire le morbide songs esotiche dei Japan con le progressioni sinfoniche degli Ultravox. E sono, ad ogni modo, tanti i gruppi poco o nulla considerati, perché ritenuti troppo easy (come se scrivere una bella canzone di successo fosse una colpa!): pensiamo agli Alarm (che solo distrattamente sono stati bollati come una ‘brutta copia’ degli U2), agli americani Animotion (che seppero portare negli USA, la tradizionale patria del rock più sanguigno, le melodie del synth-pop), i nostri indimenticati Krisma (passati da sperimentazioni alla Tangerine Dream negli anni Settanta ad un intelligente pop elettronico, durante la decade successiva), sempre in Italia al primo Garbo (che riecheggiava Eno e il Bowie berlinese del 1977-79), ai tedeschi DAF (nati con il kraut rock più astratto e sperimentale) e Alphaville (numeri 1 con Forever Young, ma anche collaboratori del grande Klaus Schulze), agli Art of Noise ed agli Yello (lo spessore delle cui sperimentazioni non può e non deve esser appiattito solo svalutando alcuni singoli di più facile presa), ai Talk Talk (capaci sempre di reinventarsi e di rimettersi in gioco), ai Level 42 (che non furono solo il gruppo della hit Lessons in Love, ma anche una grande band di jazz rock, come attestano il primo omonimo, il doppio live e il primo LP solista del tecnicissimo Mark King, uno dei più grandi bassisti degli ultimi quattro decenni). Né dobbiamo, poi, condannare senza diritto di replica Mission e Bolshoi, solo per avere reso più fruibile il gothic-dark di Leeds e di Londra.
Altro mito da sfatare è quello di una new wave che romperebbe i ponti con il passato (leggasi i ’70), quando, in realtà, è vero spessissimo il contrario: i grandiosi Magazine, di Manchester, ed i Fiction Factory (una splendida meteora del 1984) seppero riportare in auge ed aggiornare in una chiave più melodica la lezione dei Roxy Music di Brian Ferry. Questi ultimi influenzarono non poco anche gli A Flock of Seagulls, di Liverpool, tra i pochissimi artisti che introdussero nel synth-pop la chitarra, strumento che era stato, per un certo periodo, accantonato. Né vanno dimenticati gli All About Eve (che rilessero con gusto ed in una direzione tra ambient e dark-wave il prog lirico e neo-classico dei Renaissance), i comunque gradevolissimi New Musik, il geniale Thomas Dolby (che iniziò con il kraut elettronico tedesco, prima di diventare solista di pregio, produttore ricercatissimo ed autore di colonne sonore, tra le quali Gothic, il visionario e barocco film dedicato da Ken Russell a Shelley e Byron). Persino i norvegesi A-Ha, dopo il boom di Take on Me (1985), seppero maturare, donando, con Scoundrel Days (1986) e Stay on These Roads (1988), perle luminose di nordica intensità. Oggi come riascoltare i dischi ed i gruppi censiti in questa rassegna? Accantonando idiosincrasie, aprendo la mente, evitando letture pre-costituite, allontanando una volta per sempre rigidi quanto ideologici e vuoti schematismi. E soprattutto mettendo finalmente da parte la sciocca equazione successo=pop commerciale=musica senza valore.