Funeral Tears – Beyond The Horizon

In quasi un’ora, Nikolay Seredov riesce a convogliare con grande proprietà compositiva le varie fonti di ispirazione che vanno a comporre questo bel monolite sonoro di puro e melanconico dolore.
Danzig – Black Laden Crown

E’ apprezzabile da parte di Danzig la voglia di rimettersi in gioco con del materiale inedito, quando molti altri, alla sua stessa età, si limitano a vivacchiare sulle produzioni del passato, e qualche brano riuscito rende Black Laden Crown un album non del tutto superfluo, anche se purtroppo il confronto con i lavori composti nei primi anni novanta si rivela impietoso.
Decemberance – Conceiving Hell

Conceiving Hell per essere apprezzato pienamente va ascoltato diverse volte, dopo di che si manifesterà inesorabile in tutta la sua bellezza.
Where The Sun Comes Down – Welcome

Avvicinatevi con le dovute precauzioni a questo primo lavoro dei Where The Sun Comes Down, ci vuole la giusta esperienza per entrare nel buio della cantina dove si svolge la liturgia mistica che ancora una volta vede presente, in veste di sacerdoti mefistofelici, una buona fetta dell’heavy doom di scuola italiana, forse il genere non convenzionale in cui siamo più famosi.
Buioingola – Il Nuovo Mare

I Buioingola spaziano su assi differenti e, partendo da una base crust, sviluppano un suono molto originale con inserti neo industrial, incursioni nel doom, soprattutto perl’incedere, e tanta oscurità.
Façade – Loathe

Sia pure con gli scostamenti minimi che il genere consente, i Façade riescono nell’intento di offrire un lavoro eccellente e dalla cifra stilistica piuttosto personale, finendo per non assomigliare in maniera particolare a nessuno tra i nomi di riferimento del settore.
Sabbath Assembly – Rites Of Passage

Un disco dolcissimo e tremendo, un metal pop liberty che è concepito e suonato in maniera straordinaria, per un gruppo che continua a stupire facendo musica di qualità altissima.
Heavy Temple – Chassit

La musica racchiusa in Chassit, secondo ep degli Heavy Temple, trio nato da un sabba in qualche locale di Philadelphia cinque anni fa, la si può senz’altro descrivere come un trip di rock vintage alla massima potenza.
King Woman – Created in the Image of Suffering

Una buona prima opera da una band che “condensa” doom emozionale con shoegaze e post rock.
Funeralium – Of Throes And Blight

Un disco magnifico, ma da maneggiare con estrema cura anche da parte di chi frequenta lidi sonori contigui al funeral doom.
Longhouse – II: Vanishing

I Longhouse, seppure nell’ambito di un territorio angusto come quello del doom, brillano proprio per la loro versatilità, evitando la reiterazione stilistica lungo tutti i brani e riuscendo anche con buon successo a districarsi lungo minutaggi importanti.
The Doomsday Kingdom – The Doomsday Kingdom

Questo nuovo capitolo della carriera di Leif Edling troverà spazio su molte delle classifiche di fine anno riguardanti il metal dalle sonorità classiche, c’è da scommetterci.
Neos – Neos

Lo stile musicale di Nika prende le proprie basi dal doom, le ammanta di un piacevole alone di “kosmische musik” e, tra pulsioni psichedeliche e post metal, convince ed avvolge il giusto rendendo il lavoro decisamente apprezzabile.
The Obsessed – Sacred

“Signori” si nasce! Wino può ancora insegnare l’arte di fare grande musica.
Ell – Sweetest Nightmare
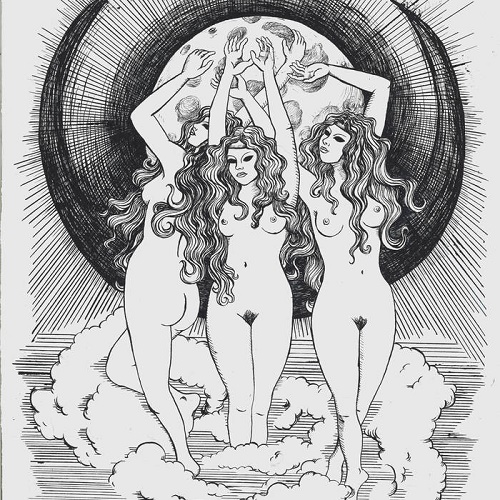
Sweetest Nightmare è un’opera breve ma di notevole interesse, almeno per chi ha voglia di scavare un po’ sotto la superficie degli album e non si stanca di andare alla ricerca di realtà intriganti e dal notevole potenziale
Ruin – Ruin

L’opera prima dei Ruin è senz’altro valida, magari non ancora all’altezza delle migliori espressioni del genere, ma ricca di spunti interessanti che fanno ragionevolmente ritenere i due musicisti dell’Alberta in possesso di tutti i mezzi per incidere, con ancor più efficacia e convinzione, alla prossima occasione.
Calliophis – Cor Serpentis

Cor Serpentis è un lavoro di grande compattezza e di altrettanta qualità, al quale manca forse il picco emotivo capace di attrarre fatalmente l’appassionato, ma che regala ugualmente un’interpretazione della materia ben al di sopra della media.
Space Witch – Arcanum

Un sound che è più di quanto disturbato si possa trovare in giro se si parla di doom metal, una musica che rispecchia jam drogate e pesantissime, un labirinto sonoro dove ragione e pazzia vivono divise da una linea sottile.
Frailty – Ways Of The Dead

Questo ritorno dei Frailty mostra una decisa sterzata verso un indurimento sonoro che, comunque, non snatura l’indole doom della band, ma ne sposta con più decisione le coordinate sonore verso il death.
Kaunis Kuolematon – Vapaus

Quello che fino a qualche anno fa era una gruppo in chiara ascesa può essere considerato, fin da oggi, una realtà tangibile ed affermata, perché comporre due album di siffatto valore è prerogativa solo delle band di levatura superiore alla media.
