SkeleToon – The Curse of the Avenger

La produzione al top e la prova sontuosa di un vocalist che lascia senza fiato aggiungono valore al cd, la cui custodia non può mancare vicino al lettore di ogni amante del power metal melodico.
Myrath – Legacy

Legacy è l’album che DEVE consacrare questa risplendente realtà musicale, trattandosi della naturale finalizzazione di un talento non comune
No Man Eyes – Cosmogony

Per gli amanti di Nevermore, Symphony X ed Angel Dust, serviti con abbondanti dosi di thrash ed una spruzzata di neoclassicismo malmsteeniano, la band genovese potrebbe essere un micidiale cocktail di cui ubriacarsi senza pensare alle conseguenze
Thunder Lord – Prophecies of Doom

Se siete fans del power speed metal un ascolto al disco potete tranquillamente darglielo, ma senza nutrire particolari aspettative, altrimenti passate pure oltre.
Sarasin – Sarasin

Non mancano buone intuizioni, che portano la band ancora più indietro nel tempo, fino ai tardi seventies, così che, questo album omonimo risulta vario, tra rudezza heavy rock, arpeggi e sfumature tradizionali.
Sleepy Hollow – Tales Of Gods And Monsters
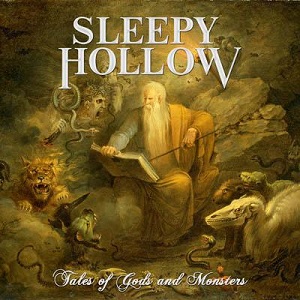
Il nuovo lavoro continua la tradizione musicale del gruppo statunitense, ottimo esempio di US metal old school amalgamato a sonorità classic doom, epico, fiero e declamatorio
Holocaust – Predator

Predator ha nelle sue virtù, quella di non apparire come una mera operazione nostalgica, ma un lavoro di un gruppo di ottima qualità al quale il passare del tempo non ha scalfito, grinta e talento compositivo.
Tarchon Fist – Celebration

Per tutta la durata dell’album vi troverete al cospetto di musica fieramente metallica e di prim’ordine, devota alla scena tedesca in primis, ma che non dimentica chi il genere lo ha inventato all’alba del decennio ottantiano sull’isola britannica.
Primal Fear – Rulebreaker

Rulebraker è quella combinazione di note immortali, amplificate e suonate al limite dei watt disponibili che la storia conosce come heavy metal, punto.
Brainstorm – Scary Creatures

Scary Creatures conferma quanto di buono fatto in vent’anni di carriera dalla band tedesca che, a distanza di un paio d’anni dall’ultimo Firesoul, regala un album irrinunciabile per gli amanti del power.
Ravensire – The Cycle Never Ends

Per gli amanti dell’heavy metal classico, l’album è una raccolta di canzoni perfette per tornare, ancora una volta, ad immergersi nelle atmosfere del genere e godere del suo spirito più puro.
Shotgun Justice – State of Desolation

L’esordio della band vive tra alti e bassi, risultando nella sua totalità un lavoro sufficientemente piacevole, specialmente per i fans dei suoni classici.
Primitiv – Immortal & Vile

Candlemass, Black Sabbath, Obituary, Morbid Angel, Cathedral e tanto talento, fanno parte del dna di questo notevole gruppo indiano, ed il loro album un disco da avere assolutamente, specialmente se siete amanti di queste sonorità.
Blackhour – Sins Remain

Il 2016 inizia come meglio non potrebbe per la Transcending Obscurity, label asiatica mai avara nel proporci ottime realtà metalliche provenienti da quei lontani paesi.
Cauldron – In Ruin

Una band onesta, un sound che è storia del nostro genere preferito, ed un lotto di buone canzoni, fanno di In Ruin un album consigliato agli amanti dell’heavy metal tradizionale di scuola ottantiana.
Teramaze – Her Halo
Her Halo conferma l’assoluta qualità della band australiana ed il talento dei suoi protagonisti.
Praying Mantis – Legacy
Legacy risulta un lavoro imprescindibile, sopratutto perchè suonato da una band storica, dall’esperienza enorme e dal talento smisurato,
Mad Max – Thunder, Storm & Passion
Compilation celebrativa per la lunga carriera dei tedeschi Mad Max, un pezzo di storia dell’hard’n’heavy europeo.
Katana – The Greatest Victory
The Greatest Victory non è altro che un ottimo album di heavy metal old school, ma con i piedi ben piantati nel nuovo millennio.
As Darkness Dies – As Darkness Dies
As Darkness Dies ha la virtù di crescere con gli ascolti, trattandosi di un album assolutamente non usa e getta ma da godersi in tutta la sua fierezza metallica
