Vampillia – Happiness Brought By Endless Sorrow
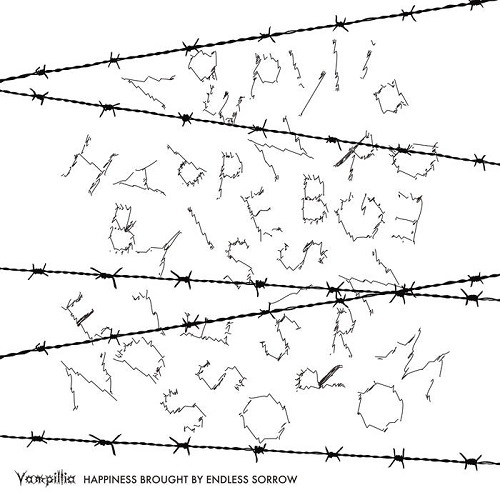
Sei minuti di musica riescono nell’impresa di coinvolgere in un modo sorprendente, quattro brani dove sono racchiusi i generi più importanti della musica contemporanea.
Hertz Kankarok – Make Madder Music

Hertz Kankarok conferma e rafforza le impressioni destate in occasione dell’esordio, offrendo con questo nuovo ep intitolato Make Madder Music un’altra mezz’ora abbondante di sonorità fresche e imprevedibili.
Death.Void.Terror. – To the Great Monolith I

To the Great Monolith I si rivela un’esperienza sonica spiazzante o devastante, a seconda di quale sia il grado di compenetrazione di ciascuno verso questo impietoso approccio musicale.
A Cunning Man – To Heal a Broken Body

To Heal a Broken Body è arduo da descrivere, meglio allora ascoltarlo: questi due ragazzi hanno del talento da vendere e l’augurio è che si possa sentire parlare di loro anche in futuro, magari ritrovandoli alle prese con un’uscita su lunga distanza capace di dare la reale misura del potenziale in loro possesso.
Malnàtt – Pianura Pagana
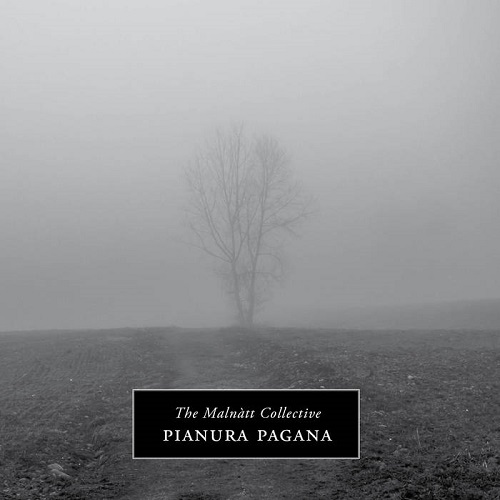
Musicalmente è forse l’album più maturo del collettivo, molto completo dal punto di vista compositivo, e quasi pronto per essere trasposto in una piece teatrale, perché in fondo questo dei Malnàtt è teatro con musica pesante.
Lychgate – The Contagion in Nine Steps

La terza opera della band albionica incute soggezione, non tanto per la mole quanto per la grande quantità di idee, di personalità, di suoni presenti nei sei brani; un vortice di atmosfere vincolate a un suono funeral e black molto personale, cangiante e che non ha eguali nell’attuale scena musicale.
Gnaw Their Tongues – Gendocidal Majesty

L’olandese Mories sforna sempre cose interessanti e potentissime, visioni allucinate di un tempo sospeso dove tutto è possibile, un’esperienza che vale la pena fare, tenendo sempre presente che non si tratta di musica, ma un canale dimensionale.
Arkheth – 12 Winter Moons Comes the Witches Brew

Ormai le sperimentazioni in ambito black metal si palesano con tale frequenza che rischiano quasi non stupire più. Proprio per questo, chi si cimenta sulle vie aperte da qualche audace pioniere nel passato, per ottenere la giusta attenzione ed un meritato riscontro non deve limitarsi a gettare nel calderone qualsiasi elemento gli frulli per la […]
Âqen – Méditation Astrale

Il black metal di Âqen è un qualcosa che va oltre il genere, ci si muove nelle vicinanze dell’atmospheric, ma ci sono anche intarsi di folk, perché la poetica del francese deve molto all’occulto, al mondo che sta oltre e dentro di noi.
Hardcore Anal Hydrogen – Hypercut

Hypercut è un album che magari si farà fatica ad ascoltare dalla prima all’ultima nota, ma può rivelarsi molto interessante per chi ritiene terribilmente scontata la musica, per così dire, “normale” …
Ophe – Litteras Ad Tristia Maestrum Solitude
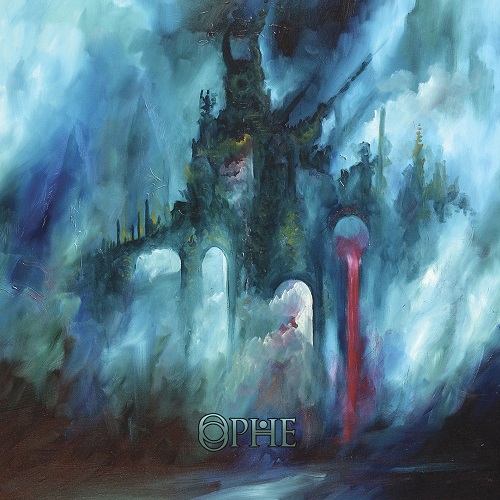
Nonostante quella targata Ophe sia una forma di avanguardismo quanto mai estrema, l’album possiede una sua logica, per quanto a tratti destrutturata, riuscendo così ad attrarre piuttosto che respingere ogni tentativo d’approccio.
Greyfell – Horsepower

Qui si degustano i fiori del male, come diceva un connazionale dei Greyfell, e il tutto è pervaso da un dolce incantesimo malvagio, che vive di groove pesante e voli nelle varie sfere grazie alle tastiere e synth.
Monolithe – Nebula Septem

Ancora una volta i Monolithe fanno centro, dimostrando che si può conservare la propria identità anche apportando diverse variazioni al tema portante, che resta pur sempre l’ideale accompagnamento sonoro dei viaggi intrapresi dalla nostra immaginazione al di là del tempo e dello spazio.
Almyrkvi – Umbra

L’operato di Jónsson colpisce per maturità e qualità e, laddove l’aggettivo atmosferico rischia d’essere utilizzato a sproposito, sicuramente l’interpretazione del genere targata Almyrkvi è molto lontana da quella tradizionale.
Minipony – Imago

Dischi come questo mostrano quante potenzialità ancora inesplorate ci siano nella musica pesante, un viaggio che continua.
Urarv – AURUM

Aldrahn, il carismatico leader, afferma “we’re traveling to remote regions of metal music and mental space with this music”. Sono sicuramente sulla buona strada!
Blut Aus Nord – Deus Salutis Meæ

Chapeau a Vindsval, unica mente dei Blut Aus Nord che, dopo venti anni di musica estrema, dimostra una creatività senza pari, presentandoci un’opera breve ma intensa e ricca di stimoli emozionali.
Fleurety – The White Death

I Fleurety continuano bellamente a fregarsene di ogni convenzione e riversano sull’ascoltatore un groviglio di suoni che trovano una loro effettiva ragione d’essere nelle sole occasioni in cui la forma canzone prende realmente corpo.
Bushi – Bushi

Bushi è un disco originale e un tentativo di cambiare le coordinate della ricerca musicale in campo pesante, perché qui è usato ad esempio con molta intelligenza anche il pop.
In Human Form – Opening of the Eye by the Death of the I

Quella degli In Human Form è un’espressione musicale oggettivamente elevata quanto ambiziosa, ma rivolta inevitabilmente ad un’audience molto ristretta, che corrisponde appunto a chi apprezza in toto tutto quanto sia sperimentale ed avanguardista.
