OGNI DOMENICA ALLE 22, ALL’INTERNO DI OVERTHEWALL
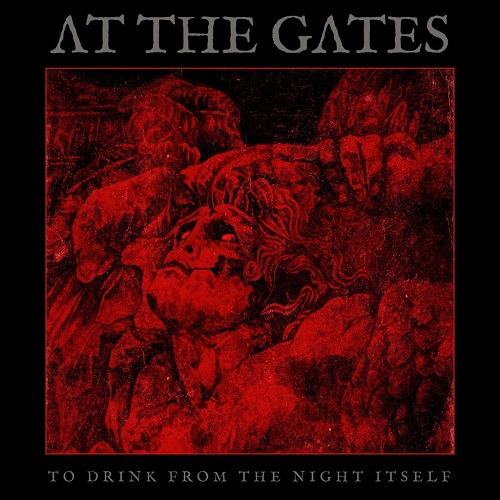
Nel corso del programma condotto da Mirella su EnergyRadio, avremo uno spazio di qualche minuto nel corso del quale porteremo in evidenza i migliori dischi da noi recensiti nel corso della settimana. Qui è disponibile la versione testuale dell’ultima puntata.
The Dead Daisies – Burn It Down

Burn It Down è il quarto album in studio e la band fa un ulteriore balzo temporale all’indietro, inglobando in un sound che ha sempre poggiato le basi negli anni ottanta impulsi rock blues del decennio precedente, come se John Corabi e compagni avessero lasciato gli Whitesnake dopo il loro approdo a Los Angeles, per recuperare quelli più rudi e selvaggi delle origini.
Deadly Carnage – Through the Void, Above The Suns

Questo nuovo album si rivela un altro passaggio evolutivo di un percorso artistico in costante crescendo, sempre contraddistinto da sonorità non del tutto convenzionali e, nel contempo, volte a scuotere quello stato di apatia emotiva nel quale si consuma l’esistenza dell’uomo moderno.
Lenore S. Fingers – All Things Lost On Earth

Un disco così profondo, intenso e nel contempo delicato, poteva scaturire solo dall’incontro tra il triste disincanto del gothic dark di matrice nordica ed il tepore mediterraneo, capace di sciogliere il ghiaccio trasformandolo in lacrime liberatorie.
Necrodeath – The Age Of Dead Christ

The Age Of Dead Christ è il ritorno di una delle più importanti band metal italiane: il loro thrash black metal continua a mietere vittime e i trentatré anni passati dal primo storico demo non hanno lasciato alcuna cicatrice.
Aeonian Sorrow – Into The Eternity A Moment We Are

Gli Aeonian Sorrow si rivelano il veicolo ideale per portare definitivamente alla luce il dirompente potenziale di un’artista a 360 gradi come Gogo Melone.
Troll – Troll

Troll è un debutto di assoluta bellezza, che unisce il miglior prog degli anni settanta con la magia del rock e con un pizzico di metal, vivendo di soluzioni sonore molto belle e durature, le cui trame si espandono nelle nostre menti.
Infection Code – Dissenso

Ogni minuto di questo disco è stato composto, lavorato e pensato per cancellare la forza della matrice che governa le nostre vite
Embryo – A Step Beyond Divinity

A Step Beyond Divinity è un’opera dal taglio internazionale che incolla l’ascoltatore alle cuffie, un dirompente fiume metallico che straripa tra debordanti e possenti passaggi estremi, orchestrazioni epiche ed apocalittiche e chitarre che sanguinano melodie.
Kantica – Reborn In Aesthetics
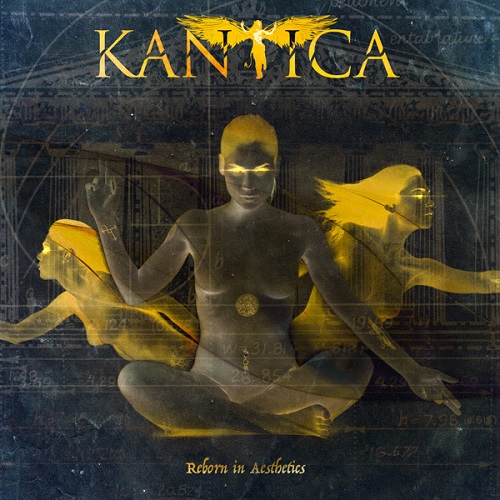
Una produzione da top band, una cantante che incanta ed ammalia e cinque musicisti che formano una squadra compatta ed assolutamente vincente, sono le prime avvisaglie di un’opera ottima in ogni dettaglio, creata per far innamorare gli (ancora tanti) estimatori del power metal sinfonico.
Wrath Sins – The Awakening

The Awakening stupisce ed esalta, dalla produzione al songwriting, dalla tecnica con cui è suonato fino all’atmosfera che rimane di tensione estrema dalla prima all’ultima nota.
Nortt – Endeligt

Sono passati dieci anni ma Nortt sembra ancora più convinto nell’esplorare oscuri e vuoti abissi, ove non risiedono speranza ma solo morte e desolazione.
Corrosion Of Conformity – No Cross No Crown

I Corrosion Of Conformity sanno suonare rock pesante e licenziano un altro best seller che si aggiunge alla loro discografia, alzando l’asticella quanto basta per risultare inarrivabili per almeno il 90% dei gruppi odierni.
Slow – V-Oceans

Dall’Aurora alle Tenebre, dal Diluvio al Nulla, per chiudere ineluttabilmente con la Morte: giocando con i titoli dei brani è questo il percorso cosparso di lacrime lungo il quale ci conduce ancora una volta il talento di Déhà.
Häive – Iätön

E’ realmente necessario che ogni ascoltatore “open minded” trovi un po’ di tempo da dedicare ad un’opera così affascinante di dark/folk intriso di black metal.
Blaze Of Perdition – Conscious Darkness

Il quarto full length dei Blaze Of Perdition è un qualcosa che va oltre il concetto puramente estetico di black metal: qui si percepisce in maniera quasi tattile il turbinio di sensazioni che stanno alla base di un lavoro compositivo e lirico stupefacente, per qualità e profondità.
Bell Witch – Mirror Reaper

Opera magnifica intrisa di dolore, disperazione e desolazione.
Worstenemy – Deception

E’ giunta l’ora in cui la seconda apocalisse targata Worstenemy si abbatta su di voi senza lasciarvi scampo.
Ixion – Return

L’album va approcciato ben sapendo che avrà l’impatto emotivo di una carezza e non di uno scossone: stabilito questo, non vi saranno più ostacoli di sorta ad impedire che il flusso sonoro di Return attraversi gli animi più sensibili.
Genus Ordinis Dei – Great Olden Dynasty

Il death metal viene glorificato dai Genus Ordinis Dei, che ne accentuano l’epicità e la magniloquenza con sfavillanti orchestrazioni, atmosfere oscure rese drammatiche dai tasti d’avorio che ci fanno sentire circondati dalla musica.
