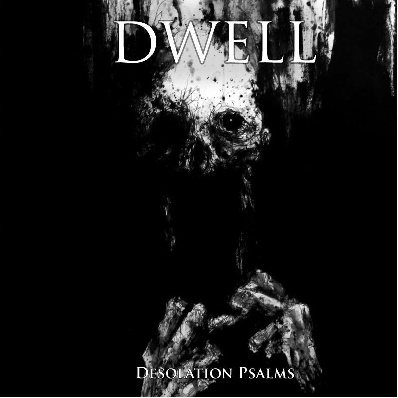Departe è uno dei capolavori dell’anno, in senso assoluto e non confinato alla nicchia del doom.
Quando qualche anno fa Daniel Neagoe, tra un capolavoro e l’altro dei suoi Eye Of Solitude, mise in piedi il progetto denominato Clouds, c’era la sensazione che potesse trattarsi di un progetto estemporaneo, per quanto splendido, alla luce di una line-up composita dal punto di vista logistico.
Oggi, anche se le redini compositive sono sempre ben salde nelle mani del musicista rumeno, con il secondo full length intitolato Departe, i Clouds fanno quel definitivo salto di qualità che conferma e rafforza il valore espresso con il precedente Doliu, facendolo apparire ancor più frutto del lavoro di una vera e propria band, e che band …
La definizione di supergruppo del funeral/death doom qui ci sta tutta e nessuno la può contestare: possiamo definire altrimenti un combo che presenta, oltre al proprio mastermind, il suo storico sodale Déhà (Deos, Slow, Imber Luminis, Yhdarl, We Al Die Laughing, e altri mille), Mark Antoniades (Eye Of Solitude), Jón Aldará (Hamferd, Barren Earth) Pim Blankenstein (Officium Triste), Natalie Koskinen e Jarno Salomaa (Shape Of Despair), Kostas Panagiotou (Pantheist, Wijlen Wij) e Shaun MacGowan (My Dying Bride)?
Non sempre la somma dei valori in campo corrisponde al prodotto finale, ed è proprio su questo punto che Departe ribalta le carte in tavola, riuscendo paradossalmente a spingersi anche oltre.
Clouds nasce come un progetto dedicato a chi non è più tra noi e questo, dal lato compositivo, si percepisce in ogni singola nota tramite la quale l’ascoltatore viene sommerso dalla commozione, il dolore ed il rimpianto, tutti sentimenti espressi da brani di bellezza irreale.
How Can I Be There è la prima gemma che si palesa alle nostre fortunate orecchie: una lunga e soffusa introduzione prepara il terreno al climax, che sopraggiungerà al momento dell’esplosione del growl di Daniel all’unisono con gli strumenti in sottofondo, seguendo un modus operandi non dissimile da quello degli Eye Of Soitude: nulla di strano, quando la mente compositiva è la stessa, ma nel sound dei Clouds è la malinconia, che questa traccia riesce a produrre a profusione, a prevalere sulla disperazione.
Migration è semplicemente uno dei brani più belli e toccanti mai ascoltati nella mia già abbastanza lunga vita di musicofilo: la voce spettacolare di Jón Aldará è il valore aggiunto, grazie a superlative clean vocals che fungono da contrappeso ad un growl catacombale e a una struttura musicale che non lacera con il suo penoso incedere, bensì penetra e si insinua sottopelle con tutto il suo carico di nostalgico rammarico.
In The Ocean Of My Tears, interpretata da Natalie Koskinen, è un altro esempio di poesia musicale, introdotta da atmosfere dal sapore folk: ciò che nel brano si perde in drammaticità, si acquisisce in levità grazie alla voce della cantante finlandese e, in fondo, si rivela un mezzo diverso per evocare ugualmente quel senso di abbandono che nell’album non viene mai meno.
In All This Dark è uno dei sempre più frequenti brani in cui le clean vocals sono utilizzate in maniera consistente da Daniel Neagoe in alternativa al growl, a conferma di una crescita esponenziale negli ultimi anni della sua tecnica vocale, il che lo ha portato ad essere una delle migliori voci del metal odierno, non solo del genere specifico: anche quest’episodio conserva un livello di pathos non comune, pur mantenendo caratteristiche quanto mai atmosferiche.
E’ uno dei decani della scena, Pim Blankestein, storica voce degli Officium Triste, a prendere la scena nella magnifica Driftwood, assieme all’inconfondibile tocco chitarristico di Salomaa, che tesse nel finale una tela di passaggi indimenticabili.
La chiusura è affidata a I Gave My Heart Away, ed è inutile sottolineare quanto si tratti dell’ennesima gemma musicale, regalata a chi ne sa godere, contenuta in quest’album: chitarra, tastiere e violino producono un insieme che va a creare un contrasto esaltante con il growl, a sua volta appoggiato su un tappeto sonoro che, per quanto toccante, mostra fiochi barlumi di luce.
I Clouds rappresentano l’altra faccia della medaglia degli Eye Of Solitude, a ben vedere: se questi ultimi raffigurano in maniera tragica ed aspra il malessere esistenziale e la conseguente reazione all’ineluttabilità di un destino già scritto, i primi prefigurano una sorta di rassegnata accettazione di tutto questo, esprimendola con un sound più atmosferico e soffuso, dai toni consolatori.
Se vogliamo, anche il passaggio dal lutto (Doliu) alla lontananza (Departe) porta su un piano differente l’elaborazione del dolore: nel primo caso si descrivono la fase del distacco e le inevitabili lacerazioni che esso provoca, mentre nel secondo chi è scomparso fisicamente viene idealizzato spiritualmente in un non-luogo, il che consente di conservarne con nitidezza il ricordo, finendo per esacerbare ancor più il rimpianto .
Departe è uno dei capolavori dell’anno, e questo sia chiaro, in senso assoluto e non confinato alla nicchia del doom. Qui siamo di fronte ad un’opera d’arte musicale che travalica generi e mode, peccato per chi pensa che la musica debba essere solo allegra, con la finalità di far muovere le membra umane in una grottesca e plastificata simulazione di felicità; i Clouds, al contrario, conducono ad un’estasi raggiungibile necessariamente tramite una catarsi emotiva indotta dalla tristezza.
Qualcuno ha scritto che un essere umano incapace di emozionarsi fa paura: sottoscrivo in pieno.
Tracklist:
1. How Can I Be There
2. Migration
3. In the Ocean of My Tears
4. In All This Dark
5. Driftwood
6. I Gave My Heart Away
Line-up:
Daniel Neagoe – Drums, Vocals
Jarno Salomaa – Guitars
Déhà – Guitars, Bass
Kostas Panagiotou – Keyboards
Jón Aldará – Vocals
Pim Blankenstein – Vocals
Eek – Drums
Mark Antoniades – Guitars
Natalie Koskinen – Vocals
Shaun MacGowan – Violin
CLOUDS – Facebook