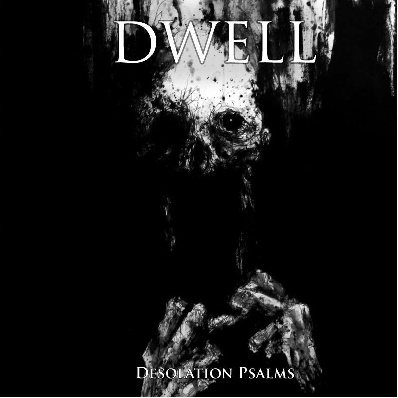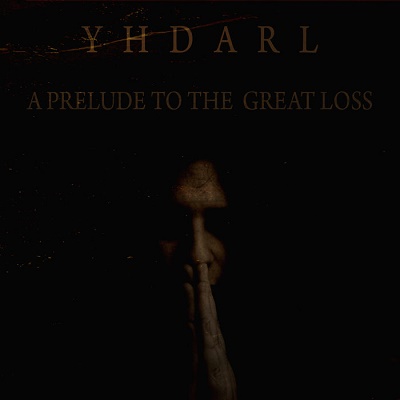Quando si parla di crossover si immagina sempre un qualcosa che vada ad intrecciare, a volte anche in maniera forzata, sfumature musicali che, prese singolarmente, si muovono in direzioni opposte.
Il caso dei Khemmis è leggermente diverso, perché qui il crossover avviene all’interno di uno dei generi più nobili del metal, il doom, cercando di farne convivere le radici classiche con la psichedelia dello stoner e la greve pesantezza dello sludge.
Capita così di imbattersi, nel corso di questo secondo album della band del Colorado, in brani in cui l’afflato melodico talvolta indolente del doom tradizionale si sposa con rallentamenti limacciosi, all’interno dei quali, magari, assoli chitarristici di matrice heavy provano a dissipare il velo di oscurità portato dal growl e dai riff pachidermici.
Tutto sommato l’operazione, a ben vedere non molto consueta, pare riuscire ai Khemmis: le cinque lunghe tracce funzionano bene e, pur senza toccare vette epocali, si rivelano efficaci esempi di quanto anche il doom possa trovare al proprio interno spunti relativamente innovativi.
In effetti, i Khemmis dovrebbero ricevere apprezzamenti trasversali, visto che il loro particolare approccio potrebbe risultare più gradito che ostico a coloro che sono devoti ad uno stile specifico.
Un buon lavoro di squadra (due buone voci, una chitarra brillante senza cadere nel virtuosismo sterile ed una base ritmica sempre ben percepibile) che fornisce un risultato più che soddisfacente: Hunted è il degno seguito di un Absolution che aveva già convinto lo scorso anno critica ed appassionati, segno che la strada intrapresa è sicuramente quella giusta.
Tracklist:
1. Above The Water
2. Candlelight
3. Three Gates
4. Beyond The Door
5. Hunted
Line-up:
Dan – Bass
Zach – Drums
Phil – Vocals, Guitars
Ben – Vocals, Guitars
https://www.youtube.com/watch?v=kbNgdEfMVng