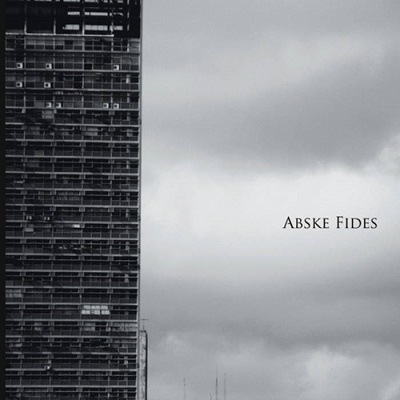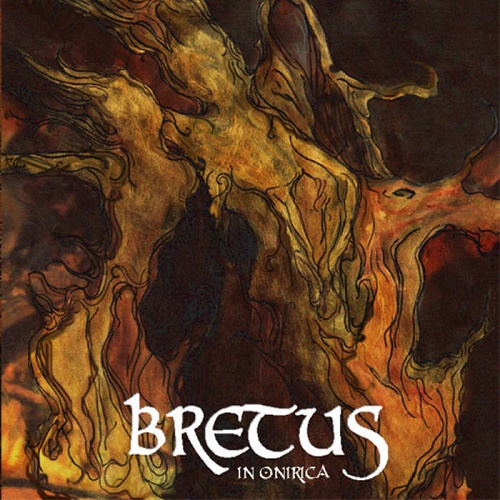Visto che, mentre scrivo questa recensione, ci troviamo in pieno periodo olimpico, mi è venuto spontaneo pensare che gli Evoken siano, assieme ai Mournful Congregation e agli Skepticism, i più autorevoli candidati a un ipotetico podio nella specialità del death-doom.
La band del New Jersey ritorna con un full-length a cinque anni di distanza da “A Caress Of The Void” e, come sempre, non delude le attese raggiungendo probabilmente uno dei punti più alti di una già splendida carriera.
La capacità di immergere l’ascoltatore in atmosfere plumbee e soffocanti, senza risultare mai noiosi o ripetitivi, è privilegio di pochi eletti dei quali gli Evoken fanno parte a buon diritto.
Rispetto a quanto fatto lo scorso inverno con “The Book Of Kings” dai succitati australiani, i nostri accentuano, come da attitudine, la componente death, privilegiando un impatto maggiormente basato sui riff di chitarra pur non disdegnando passaggi acustici, per lo più racchiusi nei due brevi strumentali A Tenebrous Vision e Requies Aeterna.
Se le chitarre assumono un ruolo preponderante nel sound dei maestri statunitensi, le tastiere svolgono un sapiente lavoro di raccordo caratterizzando con rara efficacia i momenti di maggiore intensità e pathos.
Atra Mors viene inaugurato dalla title-track facendo capire sin dalle prime note che, nonostante nulla sia cambiato, il dolore continua a rinnovarsi in maniera costante alimentando in una catena senza fine i rimpianti, le disillusioni e la disperazione per un cammino che, giorno dopo giorno, si avvicina sempre più alla sua fine.
Questo terrificante viaggio nei recessi più profondi della psiche umana prosegue con la meraviglia rappresentata da Descent Into Chaotic Dream, il cui assolo di chitarra finale è poesia allo stato puro.
Grim Eloquence e An Extrinsic Divide proseguono con il loro lento incendere verso il momento del definitivo distacco, ma è con le atmosfere a volte dissonanti di The Unechoing Dread che le tenebre finiscono per avvolgerci impietosamente, con il magistrale growl di John Paradiso a infierire definitivamente sul nostro spirito già sufficientemente provato.
Into Aphotic Devastation conclude, passeggiando senza misericordia sui nostri miseri resti mortali, questo percorso lastricato di sofferenza al termine del quale provo a immaginare la domanda che formulerebbe spontaneamente chi non è avvezzo a questo tipo di musica: per quale motivo dovrei sopportare tutto questo ?
La risposta è che il death-doom non è solo una forma artistica caratterizzata da una rara integrità e aliena a qualsiasi tipo di compromessi: ascoltare opere del valore di Atra Mors ci ricorda in modo costante e senza remissione il carattere aleatorio della nostra esistenza, invitandoci così ad affrontarla quotidianamente con la giusta consapevolezza e il necessario disincanto, prima che tutto si concluda ineluttabilmente con l’approdo in “… a soundless realm, an unforgiving place where time seems endless …”
Un disco imperdibile.
Tracklist :
1. Atra Mors
2. Descent into Chaotic Dream
3. A Tenebrous Vision
4. Grim Eloquence
5. An Extrinsic Divide
6. Requies Aeterna
7. The Unechoing Dread
8. Into Aphotic Devastation
Line-up :
John Paradiso Guitar, Vocals
Chris Molinari Guitar
Nick Orlando Guitar
Dave Wagner Bass
Don Zaros Keyboards
Vince Verkay Drums